Educazione democratica, ricerca scientifica, impegno politico e femminismo attraverso la vita di Irène Joliot-Curie
Raffaele Cariati
Insegnante e formatore per docenti in servizio per Canalescuola, membro CEMÉA France
e-mail: rcariati@canalescuola.it
Indice 2. Formazione di uno spirito scientifico democratico 4. Far progredire la causa femminista – «Faire avancer la cause des femmes» 5. L’impegno politico: lotta antifascista e diritti economici delle donne 6. Attualità delle vicende umane di Irène Joliot-Curie Abstract. The communist sympathizer Irène Joliot-Curie received an offer to join the government from Léon Blum, after the victory of the Popular Front in the second round of the parliamentary elections on 3 May 1936.
Irène Joliot-Curie, Nobel prize winner in Chemistry in 1935, based on the work of Marie and Pierre Curie, who isolated some natural radioactive elements, succeeded in transmuting certain elements (such as boron, aluminum and magnesium) into synthetic radioactive isotopes. It appears, therefore, as the most daring appointment of Léon Blum. Republican, secular, progressive, will pass, not without leaving a mark in the state undersecretariat for scientific research.
Researchers in mathematics and science education often stress the current and urgent need for humanization of teaching practices by interfacing them with history, the environment and the narrative of how scientific research also shapes the formation of a scientific spirit that commits politically towards the construction of a common good for all society.
Very often in the classroom, in the name of the god of presumed effectiveness, teaching is oriented mainly towards algorithmic practices and semiotic treatments. A transdisciplinary reflection on the biography of Irène Curie, understood as a pedagogy of choice and commitment, can be an opportunity to strengthen the positioning of the dissemination of chemical sciences in space, in the time and complex and heterogeneous system of democratic scientific education. Keywords: Curie; educazione scientifica democratica; femminismo; pedagogia dell’impegno; radioattività naturale; radioattività artificiale Irène Joliot-Curie (1897-1956) è una personalità dal triplice valore simbolico: ha ricevuto il premio Nobel per la Chimica nel 1935 (come sua madre Marie Curie), è stata una delle tre donne sottosegretario di Stato (alla ricerca scientifica) del governo Blum del giugno 1936, è stata attivista per i diritti delle donne. La sua vita attraversa tre momenti della storia dei femminismi del XX secolo. Adolescente al tempo del suffragismo trionfante della Belle Époque, poi giovane ragazza mobilitata sul fronte sanitario della Prima Guerra Mondiale, è poi moglie e madre emancipata nel periodo tra le due guerre, ma è anche una scienziata impegnata politicamente nel Front Populaire. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, nonostante i problemi di salute, diventa un’attivista pacifista e pro-comunista.
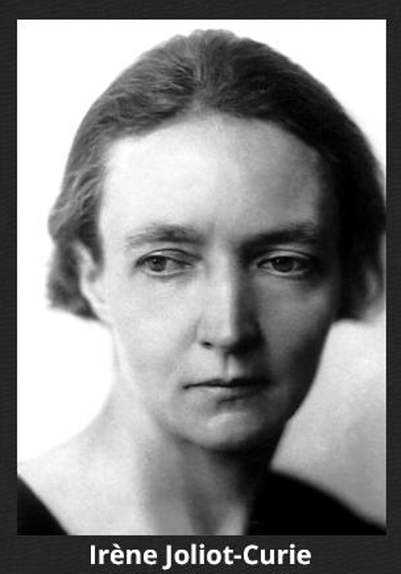
Il Front Populaire (Fronte Popolare) fu una coalizione tra il Partito Socialista (SFIO), il Partito Comunista Francese (PCF) e il Partito Radicale (che non era comunista, ma favorevole a riforme sociali), insieme ad altre forze progressiste e sindacali, con l’obiettivo di contrastare l’ascendente fascista e conservatore e migliorare le condizioni sociali e lavorative dei cittadini. La sua nascita e la vittoria elettorale del 1936 sono il risultato di una serie di eventi sociali, economici e politici che segnarono la Francia negli anni Trenta del secolo scorso: la crisi economica, la crescita del fascismo e del nazismo in Europa, la debolezza del governo della Terza Repubblica, caratterizzata da una forte instabilità politica e da una continua alternanza di governi che non riuscivano a risolvere efficacemente i problemi sociali ed economici. Questo contribuì a un crescente disincanto da parte dei cittadini, che cominciarono a cercare un’alternativa di governo che potesse affrontare le
Negli anni precedenti, il governo della Francia era dominato da forze politiche di destra e centro-destra, che non erano riuscite a rispondere adeguatamente alla crisi economica e sociale. Le politiche di austerità e la crescente polarizzazione sociale favorirono il rafforzamento dei movimenti di sinistra. I movimenti di lavoratori e sindacali si rafforzarono notevolmente a causa delle condizioni di vita sempre più difficili. La Confederazione Generale del Lavoro (CGT), il principale sindacato francese, divenne una forza sempre più attiva e influente, chiedendo migliori condizioni di lavoro, l’aumento dei salari e una riduzione dell’orario di lavoro. Questi movimenti sindacali finirono per convergere con i partiti di sinistra, culminando nella creazione del Front Populaire di cui Léon Blum, leader del Partito Socialista Francese (SFIO), divenne primo ministro. Il suo governo (dal 1936 al 1937) fu segnato da una serie di riforme sociali e lavorative che cercavano di affrontare le sfide economiche e sociali del paese.
2. Formazione di uno spirito scientifico democratico
Al femminismo silenzioso e privato incarnato da sua madre Marie Curie, un femminismo discreto di pratica quotidiana, Irène oppone un femminismo più militante e rivendicativo.1 Sensibile alla questione dell’emancipazione delle donne a causa della sua educazione progressista, laica e repubblicana, attinge dalle profondità delle idee egualitarie, come sua madre o come suo marito, Frédéric Joliot, per difendere un femminismo riformista. Nonostante un posizionamento diverso, l’evocazione della figura di sua madre diventa ricorrente nei discorsi che rivolge alle donne, soprattutto dopo il 1945.
Questo riferimento è, al di là della testimonianza personale, il mezzo per legittimare i suoi atti, le sue parole, i suoi impegni.
Nell’articolo “Marie Curie, mia madre”,2 pubblicato nel dicembre 1954, ciò che Irène afferma su Marie Curie suona come la conferma della sua stessa azione: «Ci sono state questioni sulle quali mia madre aveva opinioni di assoluta intransigenza. Per esempio, riteneva che le donne dovessero avere gli stessi diritti e anche gli stessi doveri degli uomini. [...] Riguardo al voto delle donne, mia madre ha sempre sostenuto con forza la necessità di questa riforma.» E sottolinea giustamente alcune righe più avanti: «Ero fortemente influenzata da mia madre.»
Sin da giovane, Irène Joliot-Curie ha fatto dei diritti delle donne una questione di principio e una rivendicazione politica importante. Nata nel 1897, figlia di studiosi, è cresciuta circondata da intellettuali e scienziati, dai fisici Paul Langevin, Yves Perrin, André Debierne, dai matematici Paul Appell, Paul Painlevé, Émile Borel o Henri Poincaré, tutti repubblicani laici e dreyfusardi. Indubbiamente appartiene a un segmento sociale elitario e accademico che favorisce la determinazione di una dimensione intellettuale alimentata dalla «causa e culto della scienza», che favorisce la formazione di uno spirito scientifico contaminato con l’impegno politico. Irène Curie visse sin da giovane un’esistenza di relativa emancipazione: educazione molto liberale e persino mista, nell’ambito di una cooperativa d’insegnamento. Era il gennaio 1907 e Maria Skłodowska Curie doveva spiegare a un gruppetto di adolescenti come fare per distinguere il vuoto dall’aria.3 L’ascoltavano, oltre alla figlia Irène, Aline e Francis Perrin, Jean e André Langevin, Pierre, Etienne e Mathieu Hadamard. I genitori di questi ragazzi avevano deciso di tentare un esperimento a dir poco originale. Avevano ottenuto l’esonero dei loro figli dalle lezioni liceali per sostituirle con lezioni private tenute da loro stessi.
Certo erano insegnanti che offrivano solide garanzie di provata competenza. Ad esempio, il fisico Jean Perrin era professore di chimica-fisica alla Sorbona e il suo nome è legato sia al moto browniano che alla prima determinazione sperimentale della costante di Avogadro. Paul Langevin era professore di fisica al Collège de France. C’erano poi umanisti e artisti, tra cui lo scultore Jean Marie J. Magrou.
Irène, successivamente, scelse di impegnarsi nel 1914, quando aveva solo 17 anni, nel servizio radiologico dell’esercito, istituito da sua madre. Fu un’esperienza professionale di ricercatrice scientifica in un mondo molto maschile, un percorso originale rispetto alla maggior parte delle ragazze della sua generazione.
3. L’opera scientifica di Irène Curie con Frédéric Joliot: una sinergia umana alla scoperta della radioattività artificiale
«Ciò che caratterizza veramente un lavoro di ricerca scientifica è che esso sia destinato a soddisfare una curiosità disinteressata.» Irène Curie
Due mesi dopo la discussione della sua tesi di laurea (1925), salutata con entusiasmo dalla stampa nazionale e internazionale, ad Irène viene offerta una posizione di insegnante di chimica presso l’Università di St. Lawrence, nello stato di New York. Ma lei non ha alcun desiderio di lasciare Marie Curie e il suo istituto di ricerca. Si sta formando con Frédéric Joliot, sulle tecniche utilizzate nel Laboratorio Curie e nutre sempre maggiore interesse sulle reazioni nucleari: osservare e capire le trasformazioni dei nuclei atomici sotto l’impatto delle radiazioni, questo è il suo progetto. Frequentandosi quasi ogni giorno, Irène e Frédéric si rendono conto che oltre alla scienza condividono altri interessi: lo sport, la montagna e la vita di famiglia.
Inoltre, i loro caratteri apparentemente contrastanti risultano complementari: lei è riservata, calma e riflessiva, lui è più impulsivo, socievole e pieno di entusiasmo. Si sposano nell’ottobre del 1926. Come Marie e Pierre Curie, non si separeranno quasi mai e la loro collaborazione professionale sarà molto intensa.
Il primo compito della coppia Joliot-Curie consiste nello sfruttare il tesoro di Marie Curie: per studiare gli straordinari fenomeni che accompagnano il passaggio dei raggi α nella materia, bisogna produrre delle fonti intense che emettano tali radiazioni. Il polonio è particolarmente adatto a questo scopo poiché emette principalmente solo questo tipo di radiazioni. I due scienziati cercano, quindi, di produrre i migliori «proiettili» che possano esplorare i nuclei atomici. Sviluppano nuovi processi chimici per la preparazione di fonti a base di polonio, che si rivelano di gran lunga superiori a quelle ottenute negli altri grandi laboratori mondiali (la loro intensità è di 100 millicurie, contro alcuni millicurie ottenuti altrove). La coppia lavora anche sulla qualità della strumentazione. La radioattività non è rilevabile tramite i sensi. Tuttavia, è possibile misurarne l’intensità o visualizzarla indirettamente. La camera di ionizzazione accoppiata con l’elettrometro al quarzo piezoelettrico – il dispositivo feticcio di Marie Curie – permette di determinare l’intensità delle radiazioni ionizzanti “in massa”, cioè in modo globale senza distinguere tra ciò che rientra in questo o quel tipo di raggio. Il metodo si basa sulla capacità delle radiazioni α, β o γ di ionizzare un gas, producendo così una corrente elettrica. Ricordiamo che le particelle cariche possono ionizzare un gas. Questo è il caso delle particelle α costituite da un nucleo di elio (contenenti due protoni carichi positivamente), e anche delle radiazioni β formate da fasci di elettroni carichi negativamente. Le radiazioni γ sono costituite da fotoni e la ionizzazione è secondaria. Il fotone è una particella non carica, ma può interagire con un atomo che incontra sul suo cammino e strappargli un elettrone: l’atomo diventa ionizzato perché ha perso una carica elettrica. Un tale fenomeno è definito «effetto fotoelettrico» quando, nell’interazione, il fotone è stato completamente assorbito dall’atomo, o «effetto Compton», quando lo è stato in modo parziale (un fotone secondario, meno energetico, viene allora riemesso).
L’effetto fotoelettrico fu dimostrato teoricamente da Einstein nel 1905. La luce non è solo un’onda, ma è anche costituita da particelle di massa zero – i famosi «quanti d’energia» ipotizzati da Max Planck, successivamente denominati «fotoni». Questa scoperta ha valso a Einstein il premio Nobel per la Fisica nel 1921. Un anno dopo, il fisico americano Arthur Compton fornisce la prova sperimentale dell’esistenza dei fotoni grazie alla scoperta dell’effetto che porta il suo nome, convalidando definitivamente la nozione di «dualità onda-corpuscolo» della luce.
Ritornando ai rivelatori di radioattività, due strumenti sono d’importanza fondamentale in quest’epoca.
Il primo è il contatore di Hans Geiger che ha fatto la sua apparizione nel 1913 e fu migliorato da Walther Müller nel 1928. È un dispositivo molto pratico grazie alle sue piccole dimensioni, ma non permette di conoscere né la natura né l’energia della radiazione. Fondamentalmente conta «solo» le interazioni della radiazione incidente con il gas.
Il secondo è la «camera a nebbia» che rappresenta senza dubbio il rivelatore più apprezzato dagli scienziati alla fine degli anni Venti del secolo scorso. Questa invenzione geniale è dovuta al fisico scozzese Charles Thomson Rees Wilson che, affascinato dagli effetti luminosi e dal Sole che tramonta sulle nuvole, decide di riprodurre il fenomeno in laboratorio. Egli immagina lo strumento intorno al 1897 e lo costruisce per la prima volta nel 1911. Il dispositivo è stato poi perfezionato molte volte tra il 1923 e il 1930. Solo in questo periodo ha cominciato a essere realmente utilizzato nella ricerca sulla radioattività: la camera di Wilson, infatti, permette di fotografare le tracce lasciate dalle radiazioni. Il suo principio? Creare artificialmente all’interno di un contenitore trasparente in vetro, una nebbia di vapore acqueo (o costituita da una miscela di acqua e di alcool) facendolo poi condensare, quindi formare goccioline. Come? Provocando un’espansione adiabatica del gas, che abbassando in una frazione di secondo la pressione del gas all’interno della camera, determina un raffreddamento del fondo della camera intorno ai – 40 °C. Le goccioline si formano, però, solo in condizioni particolari: nei punti dove sono presenti «germi di condensazione». Questi germi possono essere semplici granelli di polvere, ma anche ioni, prodotti dal passaggio di particelle cariche come una particella α o una particella β. Le particelle cariche hanno infatti l’energia necessaria per avviare il processo di condensazione. Dopo essersi assicurati che la camera non contenga nessun residuo di polvere, si può avvicinare una sorgente radioattiva: ogni singola particella carica è visualizzabile grazie alle migliaia o anche milioni di piccole gocce formate in seguito al suo passaggio. Questa traccia – che è simile a quella lasciata dalla condensazione di vapore acqueo che fuoriesce dai reattori di un aereo – è caratteristica della natura della particella osservata. Così, il passaggio di un elettrone (radiazione β), una particella molto leggera, lascia una traccia fine a forma di «zig-zag», mentre quello di una particella α, molto più pesante e più ionizzante, produce una traccia spessa e corta.
Inoltre, posizionando la camera a nebbia in un campo magnetico è possibile determinare l’energia della particella. Un procedimento assolutamente rivoluzionario per vedere la radioattività! Già nel 1929, Irène Curie e Frédéric Joliot effettuarono diverse ricerche comuni con questo strumento. Due anni più tardi, Frédéric progetta un nuovo tipo di camera a nebbia che funziona a pressioni molto basse, il che moltiplica per settantasei la lunghezza delle traiettorie osservabili delle particelle. Il loro lavoro si inserisce in una serie di nuove scoperte nella fisica nucleare: il neutrone, il positrone e la radioattività artificiale.4
Infatti, secondo il fenomeno di interazione elettromagnetica, due cariche della stessa natura si respingono (mentre due cariche di natura opposta si attraggono). Il protone non deve essere probabilmente l’unica particella che costituisce il nucleo. Già nel 1920, e più esplicitamente ancora nel 1927, Rutherford postulò l’esistenza di una particella neutra pur essendo consapevole che una tale particella, senza carica, sarebbe stata difficile da rilevare con le tecniche disponibili.
Rutherford ipotizza una particella neutra che interagisca con i protoni elettricamente positivi. Per lui, questa «particella elettricamente neutra» potrebbe essere composta da un protone e un elettrone intimamente legati, una nuova particella risultante delle due già conosciute. Rutherford tenta di cercarla, ma non la trova. Nel 1930, il «neutrone» che ha immaginato resta sempre una delle principali preoccupazioni del laboratorio Cavendish che dirige a Cambridge. L’enigma sarà finalmente risolto grazie a tre esperimenti, condotti in tre laboratori diversi: quello di Walther Bothe e Herbert Becker in Germania, quello di Irène Curie e Frédéric Joliot in Francia e quello di James Chadwick, un discepolo di Rutherford, in Inghilterra.
Bothe e Becker sono particolarmente interessati allo studio della radiazione γ (costituita da fotoni): suppongono che le collisioni di particelle α su nuclei atomici possano portare all’emissione di fotoni. Nel 1930, progettano un esperimento destinato a testare la loro ipotesi: bombardano atomi molto leggeri – litio, boro, berillio – con particelle α. La scelta dei «bersagli» non è frutto del caso: più un atomo è pesante e più le particelle α, caricate positivamente, corrono il rischio di essere respinte elettricamente dai protoni – anch’essi positivi presenti nei nuclei atomici senza, quindi, poter interagire con questi ultimi. Per riuscire a rilevare i fotoni γ, utilizzano una variante del contatore Geiger-Müller modificato per far passare, in linea di principio, solo questi e non le altre radiazioni ionizzanti che non erano oggetto di interesse. L’esperimento è fruttuoso e osservano bene una radiazione ionizzante neutra, cioè non carica. Non può che trattarsi, pensano, dei famosi fotoni γ! Ma quando cercano di valutarne l’energia, interponendo sul loro passaggio delle placche di piombo, constatano con stupore che questa radiazione è ostacolata solo da placche con un grande spessore. Stimano così la sua energia a circa 5 MeV, superiore a quella dei soliti fotoni gamma della radioattività, che è dell’ordine di 1-2 MeV. Tuttavia, non riescono a disfarsi dell’idea che questa radiazione ultra-penetrante, emessa dai loro bersagli, debba essere di tipo γ.
Un anno dopo, Irène e Frédéric, incuriositi dai risultati di Bothe e Becker, riproducono l’esperimento. Il loro rivelatore è una camera di ionizzazione accoppiata con un elettrometro al quarzo piezoelettrico secondo la tradizione del Laboratorio Curie. Il loro dispositivo è più sensibile alla rilevazione dei raggi γ, ma anche a quella dei protoni. Inoltre, dispongono di una sorgente di raggi α, venti volte più intensa rispetto a quella della squadra tedesca. La loro prima conclusione va nello stesso senso di quella dei loro colleghi. Tuttavia, per conoscere un po’ di più su questo misterioso e presunto irraggiamento γ, particolarmente energetico e ultra-penetrante, introducono una modifica nel dispositivo sperimentale che si rivelerà fondamentale: interpongono sul percorso uno schermo di paraffina (un composto idrogenato, capace di emettere i protoni), appena all’entrata della camera di ionizzazione. La corrente elettrica misurata dovrebbe logicamente diminuire a causa della presenza di questo ostacolo. Contro ogni previsione, aumenta: quindi si è verificato un altro fenomeno durante la collisione tra l’ipotetico irraggiamento γ e la paraffina. Irène e Frédéric sono convinti che la radiazione ultra-penetrante sia un fotone γ, capace di strappare alla paraffina un protone. Usando la camera a nebbia, visualizzano effettivamente tracce corte e spesse, caratteristiche di questa particella. La cosa sorprendente è l’energia di ogni singolo protone espulso: per spiegarla, bisogna ammettere che la presunta radiazione possieda in sé un’energia assolutamente fenomenale. La coppia Joliot-Curie pensa di aver messo in evidenza una nuova modalità di interazione dei fotoni con la materia, simile a un effetto Compton: se un fotone è in grado di strappare un elettrone da un atomo, perché non può strappargli un protone? Tuttavia, il problema dell’energia rimane intatto e questa interpretazione non li soddisfa pienamente. In effetti registrarono diverse decine di MeV, cioè un’energia più di cinque volte superiore a quella della particella α che, all’inizio della catena, ha dato loro vita! Questo sembra, però, contraddire il principio della conservazione dell’energia.
A partire da questo momento, tutto intorno a loro si accelera. I Joliot-Curie non hanno tempo per riflettere sul loro errore. Al Laboratorio Cavendish, James Chadwick, che ha letto il loro rapporto all’Accademia delle Scienze, è più che scettico sulla loro conclusione. Tanto più che, si è formato con il pensiero di Rutherford, quindi ha ben radicata nella sua testa l’idea che nel nucleo atomico possa esistere una particella neutra. Riproduce il dispositivo dei Joliot-Curie utilizzando una camera di ionizzazione più perfezionata, perché collegata ad un amplificatore, e quindi più sensibile alle radiazioni. Inoltre, fa interagire la radiazione ultra-penetrante «misteriosa» non solo con uno schermo di paraffina ma anche di elio, litio, berillio, carbonio e argon. Rileva, come i Joliot-Curie, l’emissione di protoni, ma anche di altri nuclei. Dalle differenze di valore della corrente misurata per ciascuno dei diversi schermi interposti, Chadwick riesce a calcolare la massa della particella associata a questa radiazione: «[...] Le difficoltà scompaiono se si suppone che le radiazioni sono costituite da particelle di massa 1 e carica 0, cioè neutroni.»5 È stato trovato il neutrone ricercato da più di dieci anni al laboratorio Cavendish. I protoni e altri nuclei espulsi non sono prodotti da una collisione di fotoni con gli schermi bersaglio, ma da quella di radiazioni neutroniche con questi ultimi. Il neutrone è, come il fotone, una particella non carica, ma a differenza di esso ha una massa (quella di un fotone è nulla). Inoltre, secondo i suoi calcoli, il problema dell’energia considerevole che era stata misurata da Irène e Frédéric è risolto se si suppone che questa massa abbia un valore molto vicino a quello della massa di un protone. Un anno dopo, Chadwick dimostra anche che il neutrone è una nuova particella elementare: non è una particella composta formata da un protone e da un elettrone perché la sua massa è superiore alla somma della massa di queste due particelle.
Nonostante abbiano contribuito alla scoperta del neutrone, Irène e Frédéric sono molto delusi per il loro errore di interpretazione. Il premio Nobel per la Fisica sfugge, lo vincerà Chadwick nel 1935.
Siamo ancora nel 1932. Irène e Frédéric vogliono ora studiare l’energia minima che deve possedere una particella α per dare origine ad un neutrone dopo la collisione con atomi leggeri. Una nuova sorpresa li aspetta. Nella camera a nebbia perfezionata da Frédéric (la cui entrata è, come nel loro precedente protocollo, ricoperta da paraffina), rilevano le tracce caratteristiche dei protoni espulsi dalla radiazione neutronica, ma anche quelle di elettroni con traiettorie molto strane: alcune sono curve verso destra piuttosto che verso sinistra. Per loro, la ragione è semplice: questi elettroni non si sono diretti dall’ingresso verso l’interno della camera, ma in senso inverso. Anche qui, l’ipotesi emessa da Irène e Frédéric sembra a dir poco curiosa: gli elettroni che viaggiano in senso opposto agli altri, in realtà, non sono elettroni, ma degli «anti-elettroni» o «positroni», con massa pari a quella dell’elettrone ma con carica opposta.6
Circa nello stesso momento Carl Anderson, fisico americano, ha confermato sperimentalmente l’ipotesi del matematico e fisico britannico Paul Dirac, che aveva previsto qualche anno prima, con il calcolo, l’esistenza dell’antimateria. Quest’ultima si comporta nello stesso modo della materia ma possiede una carica elettrica contraria al suo «alter ego». Per ogni particella di materia, esiste una corrispondente antiparticella (il fotone è non carico, è la sua particella e antiparticella allo stesso tempo). La loro coabitazione è impossibile: non appena si incontrano, si annichilano! Entrambe scompaiono rilasciando una straordinaria quantità di energia. All’inizio dell’universo, il Big Bang ha prodotto tanta materia quanto antimateria. Logicamente, tutte le coppie «particella-antiparticella» avrebbero dovuto annientarsi. Ma una piccola frazione di materia è rimasta, mentre quasi tutta l’antimateria è scomparsa dall’Universo, almeno in apparenza. Essa è presente solo in quantità non significative nei raggi cosmici e in alcuni elementi radioattivi. Questa asimmetria non trova ancora alcuna spiegazione nel modello standard della cosmologia, ma stimola la creatività delle autrici e degli autori di science-fiction.
Come per l’ipotesi del neutrone, Irène e Frédéric, focalizzati sulla sperimentazione, non avevano preso conoscenza del lavoro teorico di Dirac. La competizione è dura: dopo essere arrivati molto vicini alla scoperta del neutrone, i Joliot-Curie hanno mancato di poco il positrone. Ma presto avrebbero avuto il loro riscatto. Dopo aver indagato le radiazioni α del polonio, Irène e Frédéric sono interessati allo studio delle radiazioni deboli di tipo β, perché pensano che la disgregazione β del polonio possa formare un elemento che potrebbe avere un suo posto nella Tavola Periodica degli elementi chimici, quindi trattasi di un elemento chimico che non è stato ancora osservato.7 Il futuro deciderà diversamente: non scopriranno l’elemento ricercato, ma riusciranno per caso a produrre radioattività e a ricevere il premio Nobel.
La coppia utilizza nuovamente la camera a nebbia per rilevare la radiazione β del polonio. E poiché vogliono osservare solo questo tipo di radiazione, Irène e Frédéric hanno cura di circondare la loro preparazione di polonio con una lamina d’alluminio destinata a bloccare totalmente i raggi o le particelle α. Risultato: il loro dispositivo rileva bene la presenza di elettroni β in piccolo numero, ma anche di protoni e, sorprendentemente, di positroni. L’osservazione di protoni è facilmente spiegabile: si sa dalla prima reazione di trasmutazione realizzata da Rutherford nel 1917 che la collisione di particelle con il nucleo di alcuni atomi provoca l’espulsione di protoni. In questo caso, sotto l’impatto delle particelle emesse dal polonio, il nucleo dell’atomo di alluminio si è trasformato in un atomo di silicio con rilascio di un protone.
Ma come spiegare la presenza di positroni nel loro dispositivo sperimentale? Irène e Frédéric decidono di concentrare la loro indagine su questa nuova curiosità. La loro prima ipotesi è che invece dell’emissione di un protone, la trasmutazione dell’alluminio in silicio potrebbe in alcuni casi essere accompagnata dall’emissione simultanea di un neutrone e di un positrone. Infatti, da una parte il numero di carica è conservato – un neutrone e un positrone insieme hanno una carica positiva pari a 1 come il protone – d’altra parte, sanno, avendo partecipato in prima persona a questa scoperta, che l’interazione di particelle α con l’alluminio o altri elementi leggeri può portare all’emissione di neutroni. La loro ipotesi sembra del tutto plausibile, ma non ottiene l’approvazione dei ricercatori che partecipano, con Irène e Frédéric, al Congresso di Fisica a Solvay nell’ottobre 1933. L’austriaca Lise Meitner- una delle tre donne presenti in quel momento nell’assemblea con Irène e Marie Curie – mette seriamente in dubbio i loro risultati («dei positroni che provengono dall’interno del nucleo, impossibile!» Solo Niels Bohr e Wolfgang Pauli incoraggiano la coppia Joliot-Curie a continuare i loro lavori ritenendoli molto importanti.
Ecco arrivato, quindi, il momento dell’«esperimento cruciale». Nella scienza si tratta di un test finalizzato a giudicare se un’ipotesi è più soddisfacente rispetto a quella ammessa dalla comunità scientifica fino a quel momento. Irène e Frédéric vogliono verificare in un primo tempo la soglia di eccitazione a partire dalla quale vengono emessi i positroni, cioè l’energia minima che le particelle hanno bisogno per far apparire i positroni durante la reazione di trasmutazione. Se questa soglia è la stessa di quella necessaria per l’emissione di neutroni che sono riusciti a determinare un mese prima, allora è del tutto possibile che questi due tipi di particelle siano emesse in modo simultaneo. Per tale scopo, essi accoppiano la loro camera a nebbia a un contatore Geiger-Müller che «conta» solo i positroni emessi (ha il vantaggio di essere insensibile ai neutroni). L’11 gennaio 1934, Frédéric osserva che in presenza delle particelle α emesse dal polonio – e fermate dalla lamina di alluminio – il contatore emette tanti “bip”: questi suoni corrispondono all’emissione da parte dell’alluminio di positroni e sono tanto più ravvicinati quanto più intensa è la radiazione α che bombarda l’alluminio. Frédéric diminuisce, allora, progressivamente l’intensità della sorgente di radiazione α, fino a un livello troppo debole affinché i neutroni chiave possano essere osservati nella camera a nebbia.
In base alla loro ipotesi, anche l’emissione dei positroni dovrebbe essere sospesa. Ma non è così: la camera a nebbia li rileva e il contatore registra molto bene la loro presenza. Questo accade anche quando la sorgente di particelle è rimossa. Un fenomeno inatteso si è appena verificato durante l’esperimento. Frédéric avverte immediatamente Irène. Riproducono l’esperimento il 12 e 13 gennaio e ottengono gli stessi risultati:
«Siamo sorpresi nell’osservare che inseguito alla rimozione della sorgente delle radiazioni, l’emissione di elettroni positivi [positroni] persisteva per un certo intervallo di tempo, mentre quella dei neutroni scompariva; l’andamento decrescente del numero degli elettroni positivi in funzione del tempo ha lo stesso andamento esponenziale di quello di un radioelemento naturale, emettitore di elettroni negativi. Allora tutto diventa più chiaro.»8
La trasmutazione dell’alluminio avviene in realtà in due fasi: sotto l’impatto delle particelle α, l’alluminio si trasforma prima in fosforo-30, un isotopo radioattivo del fosforo-31 (stabile), che non esiste allo stato naturale. È durante questa prima fase che i neutroni vengono emessi. Poi, il «radio-fosforo», si disintegra in silicio emettendo dei positroni. Se i due stadi sono sembrati simultanei, è a causa della breve emivita del fosforo radioattivo: tre minuti e quindici secondi! Irène diversifica gli elementi chimici da irradiare: con boro e magnesio, ottiene nuovi radioelementi. Questa volta molto fiduciosi, la coppia pubblica due giorni dopo questi risultati all’Accademia delle scienze.9 La notizia suscita l’ammirazione di tutti i fisici. La coppia ha appena dimostrato che è possibile generare artificialmente la radioattività. Precisiamo che il fenomeno della radioattività artificiale è un po’ abusivamente qualificato come «nuovo» o «scoperta». Infatti, non differisce fisicamente in nulla rispetto a quello della radioattività naturale. Li distingue solo l’origine degli isotopi radioattivi: sintetico nel caso della radioattività artificiale, naturale nell’altro. Irène e Frédéric non hanno «scoperto» la radioattività artificiale, ma questo non rende meno straordinario i loro risultati alla luce delle applicazioni che ne deriveranno. Invece, hanno «scoperto» un nuovo tipo di radiazioni. Infatti, fino a quel momento si conoscevano le radiazioni α, β e γ. L’emissione di positroni, cioè di elettroni-positivi per decadimento radioattivo, non era mai stato osservato. Nelle settimane successive alla pubblicazione dei loro lavori, questa emissione sarà definita radiazione β+ in opposizione al precedente tipo di radiazione β conosciuta, dovuta all’emissione di elettroni-negativi che verrà quindi denominata β‒.
Per Marie Curie, è l’apoteosi: il lavoro di Irène e Frédéric si completa molto bene con quello che ha portato a termine con Pierre. Riesce anche ad aggiungere un capitolo sulla radioattività artificiale nel suo ultimo libro in corso. Sarà pubblicato postumo, con il titolo Radioactivité,10 nel 1935, l’anno in cui Irène e Frédéric vengono insigniti congiuntamente del premio Nobel per la chimica «in riconoscimento della loro sintesi di nuovi elementi radioattivi».
Alla cerimonia di consegna del premio Nobel a Stoccolma nel dicembre 1935, Irène e Frédéric fanno due conferenze distinte. Percepita da alcuni come figura esperta di radiochimica del team e assistente di Frédéric, Irène ha voluto parlare per prima anche degli aspetti fisici della radioattività artificiale. Invece Frédéric ha argomentato sulle nozioni di chimica. Un modo per determinare una rottura significativa sia con i pregiudizi misogini presenti nell’accademia scientifica dell’epoca che con l’eterna contesa tra fisica e chimica nel difendere i loro rispettivi campi nell’ambito ampio e complesso dello studio della radioattività. Questa trova, infatti, le sue radici nella sinergia tra le due discipline.
4. Far progredire la causa femminista – «Faire avancer la cause des femmes»
Sua madre, Marie Curie, pur favorevole al suffragio femminile, aveva sempre mostrato alcune resistenze nell’assumere posizioni pubbliche sul tema. Nel 1921, su richiesta della sua amica fisica femminista britannica Hertha Ayrton, si associò a una protesta contro l’incarcerazione di esponenti del movimento suffragista in Inghilterra, scrivendole: «Accetto che tu usi il mio nome perché ho grande fiducia nel tuo giudizio. [...] Sono molto toccata da tutto quello che mi avete detto sulla lotta delle donne inglesi per i loro diritti; le ammiro molto e faccio auguri affinché abbiano successo».11 In Francia, la sua unica presa di posizione ufficiale risale al 1925, quando decise di smentire pubblicamente Louis Barthou che aveva sostenuto, in Senato, che lei fosse ostile al diritto di voto delle donne: «Ho l’abitudine, è vero, di astenermi da ogni discussione politica, sia su questa che su altre questioni non scientifiche. Tuttavia, senza pronunciarmi sui modi di attribuzione dei diritti politici alle donne, credo che il principio sia fondamentalmente giusto e che debba essere riconosciuto.»12
Inizialmente, Irène è piuttosto critica nei confronti delle suffragette. Scrive a sua madre nel 1910, in merito alle più violente manifestazioni londinesi del movimento: «Ho notato che quasi ogni giorno un ministro inglese viene ucciso dalle suffragette, ma mi sembra che non sia un modo molto brillante di dimostrare che sono in grado di votare». Ebbe, poi, modo di conoscere Hertha Ayrton nell’estate del 1912, durante la convalescenza della madre al mulino di Highcliffe-on-Sea nell’Hampshire. In questo contesto, Irène Curie prese coscienza dell’importanza della questione dei diritti politici delle donne. Hertha è una ricercatrice di fama, ma è anche un’attivista della “National Suffrage League”, è membro fondatore della “International Federation of University Women” e del “National Union of Scientific Workers”, ha partecipato a numerose assemblee di suffragette tra il 1906 e il 1913, insieme alla figlia Barbara. Grazie allo scambio intellettuale con Hertha Ayrton, Irène Curie capisce quanto sia ingiustificato il discredito gettato sulle suffragette e sulle loro rivendicazioni dalla brutalità della campagna anti-suffragista e dalla violenza ingiustificata della repressione poliziesca.
Molto meno prudente di sua madre, Irène Joliot-Curie accetta di essere una donna d’influenza, di prendere pubblicamente posizione, di militare e difendere i suoi ideali. Anche per lei, i diritti delle donne sono una questione di principio.
Ci ritorna più volte negli anni ‘30: «Non mi sono mai chiusa nei lavori scientifici senza conservare la preoccupazione e la curiosità della vita»,13 dichiara nel giugno 1936 a Marie-Thérèse Jeanne Viel per il settimanale “Le Journal de la femme”. Ma dopo la morte della madre nel 1934, Irène Joliot-Curie invoca il femminismo di quest’ultima per meglio esplicitare i suoi impegni. Ciò diventa per lei una postura ricorrente che le permette anche di confortare il mito dell’illustre sapiente e del suo femminismo intransigente.
Nel 1925, al termine della sua tesi di laurea alla Sorbona, la nuova dottoressa in Fisica viene intervistata ed elogiata sia per il suo successo che per la sua filiazione.
Denise Moran ricorda infatti che Irène Curie: «[…] è una ragazza preceduta da un nome due volte illustre». Alla domanda «La carriera che hai scelto non ti sembra troppo pesante per una donna?» Irène risponde con perspicacia: «Affatto. Credo che le capacità scientifiche di un uomo e di una donna siano esattamente le stesse. A volte si ritiene che il risultato del lavoro di una donna sia inferiore. Una donna di scienza deve rinunciare agli obblighi mondani» e, a proposito degli obblighi familiari: «può accettarli a condizione di assumerne l’onere in più. Allora è molto pesante ma non è impossibile conciliarlo. Da parte mia, considero la scienza come l’interesse primario della mia vita.»14 Una concezione in definitiva tutta tradizionale della scienza, più o meno votata al celibato, e una visione molto borghese della donna e della complementarità asimmetrica nella coppia.
Nel 1935, l’assegnazione del Premio Nobel per la Chimica a Irène e Frédéric Joliot-Curie per la scoperta della radioattività artificiale svolge un ruolo di amplificatore mediatico di cui si impadronisce pienamente. La sua nuova notorietà, la sua filiazione prestigiosa, il suo compimento personale come donna, madre, insegnante e ricercatrice suscitano un rinnovato interesse per il posto concesso alle donne nella società. Durante convegni e seminari, Irène Joliot-Curie sa molto bene che si tratta anche di spiegare la sua passione scientifica, non solo di far conoscere il “Laboratorio Curie”, che co-dirige con André Debierne dal 1934 e, soprattutto, che si tratta di dimostrare che la scienza non ha sesso.
Da “Je sais tout” a “Vu”, da “Excelsior” a “Regards”, dal “Petit Parisien” al “Matin”, la stampa moltiplica i reportage, diffonde le fotografie della coppia costituita da Irène e Frédéric Joliot-Curie al lavoro nel laboratorio e rende più popolare il nome che hanno scelto di adottare dopo il loro matrimonio nel 1927: Joliot-Curie. L’incoronazione di questo “doppio cognome” da parte della comunità scientifica avviene nel gennaio 1936, durante una cena in onore della coppia. Il fisico Paul Langevin, che fu lo studente di Pierre Curie, dichiara: «Pierre e Marie Curie da una parte, Irène e Frédéric Joliot-Curie dall’altra, vengono a darci un simbolo, una dimostrazione decisiva di questa fecondità della collaborazione dei due sessi nel campo scientifico che possiamo considerare come una delle più alte.»
La scelta del doppio cognome, che va contro le abitudini dell’epoca, intende significare una relazione egualitaria e corona più la coppia di studiosi che ciascuno dei due studiosi. Il prestigio del nome Curie soddisfa sicuramente un bisogno di riconoscimento in Frédéric Joliot, ma l’associazione dei due nomi non traduce in modo più debole l’aspirazione di Irène alla parità. Si tratta di dare alle donne una piena visibilità sociale e politica. Per la scienziata, però, è anche importante esistere come studiosa: tutti i suoi articoli di ricerca sono firmati con “Irène Curie”. (“Joliot-Curie”, viene utilizzato per la vita quotidiana), ciò consacra quindi sia il riferimento scientifico che il riferimento femminista egualitario. “Les Joliot-Curie” era una denominazione d’origine controllata, inventata da Paul Langevin nel momento in cui la coppia ricevette il premio Nobel nel 1935.
Unione di un uomo e di una donna che conobbe alcune ore di tensione in occasione della nomina di Iréne nel governo Blum: «Mio padre, professore al Collège de France, era oggettivamente più preparato per un tale posto di mia madre. Lui era un organizzatore, non lei. Non metteva in dubbio il valore di sua moglie, ma ha avuto difficoltà a ingoiare la notizia»,15 ricorda ottantotto anni dopo la figlia di Irène, Hélène Langevin.
Irène Joliot-Curie accetta la proposta di Léon Blum di diventare, accanto a Suzanne Lacore e a Cécile Brunschvicg, una delle tre donne del governo del Front Populaire, anche «per far avanzare la causa delle donne».16
In una lettera all’amica femminista americana, la signorina Meloney, datata 19 giugno 1936, Irène Joliot-Curie presenta la sua entrata al governo come «un sacrificio per la causa femminista in Francia». La sua nomina a sottosegretario di Stato alle Ricerche scientifiche il 4 giugno 1937 sorprende la sua famiglia. Frédéric Joliot, era convinto che Irène non avrebbe accettato e che lei non avesse le competenze necessarie, ne era addirittura contrariato. Per Léon Blum, invece, questa designazione assume una triplice valenza: politica, comunicativa (inviando un forte segnale sulla questione dell’emancipazione femminile che si era impegnato a sostenere) e del prestigio che poteva derivare dall’ingaggio del nome “Curie” alla politica del Fronte Popolare.
La nomina di queste tre donne non implicò la concessione immediata del diritto di suffragio e di eleggibilità a tutte le donne. Léon Blum cercò di differire il progetto per paura della defezione dei radicali, per lo più ostili. Arrivò a imporre l’astensione dei suoi ministri durante la votazione parlamentare all’Assemblea nel luglio 1936. Il Senato rifiutò di esaminare la legge che restò una lettera morta, suscitando una virulenta riflessione di Louise Weiss: «Tre rondini non fanno una primavera!»17
Per Irène Joliot-Curie, entrare nel governo significò anche «servire la causa del lavoro femminile, minacciata in tutti i paesi.»18 A tal fine, ottiene dal suo ministro di tutela, il radicale Jean Zay, un sostanziale miglioramento del bilancio per la ricerca, il diritto all’ottenimento delle borse di studio e ai congedi per lavorare in laboratorio, il diritto al conseguimento della licenza per diventare professoresse nell’istruzione superiore e il diritto alla parità salariale con i colleghi maschi. Durante il suo breve passaggio al governo, Irène Joliot-Curie raggiunse risultati politici attraverso un progresso sintomatico: le normaliste «sévriennes» possono accedere, come i normalisti «ulmiens», ai posti nell’insegnamento superiore, invece di essere confinate solo nell’insegnamento secondario, il loro salario cessa di essere inferiore del 30% rispetto a quello dei loro colleghi. Inoltre, avendo ottenuto da Jean Zay un miglioramento sostanziale del bilancio della ricerca, riesce a moltiplicare le borse di studio, aumentando e riorganizzando i laboratori scientifici.19
Presto saranno gettate le basi di quello che diventerà il Centro Nazionale della Ricerca Scientifica (CNRS). La sua modernità salta agli occhi anche quando esprime il suo parere sulla prostituzione: non si riesce a vietarla, allora bisogna inquadrare questa attività in funzione delle leggi del lavoro e della protezione sociale.
Tuttavia, le divergenze si moltiplicano e il suo stato di salute richiede un riposo poco compatibile con l’esercizio di tali responsabilità, Irène Joliot-Curie affretta la sua partenza dal governo, che avviene il 28 settembre 1936. La sua lettera di dimissioni riflette una disillusione nei confronti dell’esercizio politico. Irène Joliot-Curie fa una scelta che rallegra Miss Meloney, stupita dall’appuntamento mancato per il diritto di voto e dal ritardo della Francia.
Nonostante ciò, secondo il giornale “La Française” che pubblica la sua lettera di dimissioni, Irène Joliot-Curie si dichiara soddisfatta di aver aperto così la porta «per facilitare l’ingresso di altre donne nel governo.»
5. L’impegno politico: lotta antifascista e diritti economici delle donne
Il clima degli anni Trenta porta Irène Joliot-Curie a modificare la sua opinione sul diritto di voto delle donne. Inizialmente, è rimasta fedele alla strada riformista, sostenendo l’idea che l’uguaglianza repubblicana può essere raggiunta solo con l’estensione dei diritti civili e politici, ma poi, nel corso degli anni difficili, è arrivata a considerare i diritti economici delle donne come una priorità.
Donna di sinistra con opinioni progressiste, Irène Joliot-Curie esprime il suo punto di vista sia nel circolo delle persone a lei più vicine ideologicamente che costituisce il gruppo “Arcouest”.20
La penisola dell’Arcouest è non lontano da Paimpol, nel dipartimento delle Côtes-du-Nord (ora Côtes-d’Armor), di fronte all’isola di Bréhat. All’epoca, una colonia di universitari si spostava lì ritualmente, guidata dallo storico Charles Seignobos, soprannominato «il capitano», e da Jean Perrin, premio Nobel per la Fisica nel 1926. La stampa dell’epoca aveva soprannominato «Sorbonne-Plage» questo falsario intellettuale, dove i più anziani condividevano il dreyfusismo, mentre i più giovani sostenevano il Partito Comunista Francese.
Irène sostiene una petizione contro l’arresto di Sacco e Vanzetti, si rallegra che André Marty, prestigioso politico ammutinato, sia eletto, mentre sconta la sua pena in prigione, e denuncia il muro di denaro con cui si confronta il Cartello delle Sinistre nel 1924. Questo è probabilmente il momento in cui Irène e Frédéric aderiscono alla SFIO (Section Française de l’Internationale Ouvrière)21 e alle lotte della Lega dei diritti umani e dell’Unione Razionalista. Non è vietato pensare che sia l’influenza degli ambienti accademici di sinistra (Paul Langevin, Jean Perrin, André Debierne), sia quella professionale (Georges Fournier, socialista attivo nel laboratorio Curie, Frédéric Joliot già esperto nelle discussioni politiche) abbiano influito nel determinare il passaggio di Irène dalla presa di coscienza politica alla militanza intellettuale.
È la mobilitazione antifascista che diventa il vettore principale della sua azione pubblica: Irène Joliot-Curie aderisce al Comitato di vigilanza antifascista nel 1934, contribuendo, con i suoi contatti accademici e le sue amicizie professionali, a metterlo in piedi. Si associa anche alle menti pensanti dell’antifascismo femminile, sotto la benevola egida di Eugénie Cotton vicina al Partito Comunista e di Gabrielle Duchêne, co-fondatrice della Lega internazionale delle donne per la pace e la libertà nel 1915. Si unisce così a Bernadette Cattaneo, Maria Rabaté, Luce Langevin, Lucie Prenant che rappresentano altrettante compagne di strada del movimento comunista che provengono dal mondo sindacale degli insegnanti.
Ma la crisi economica e la disoccupazione crescente spingono il governo Laval a rafforzare le misure deflazionistiche intraprese dal 1932, nonostante le forti tensioni sociali, mentre il clima internazionale si oscura con l’aumento dei fascismi in Germania e in Europa centrale. In questo contesto, Irène Joliot-Curie reagisce sempre più veementemente contro l’espansione di una xenofobia latente e l’incremento di fragilità delle donne salariate, situazione di precarietà che prova ad affrontare anche all’interno del suo stesso laboratorio: arrivano in Francia molti giovani ricercatori stranieri e già i primi rifugiati che provengono dall’Italia, dalla Polonia o dalla Germania; molte ricercatrici o donne tecniche e molte coppie di universitari sono direttamente interessati dai decreti leggi Laval del 1935 che impongono di limitare l’occupazione delle donne o di diminuire le loro indennità quando sono funzionari.
Da quel momento, Irène Joliot-Curie difende il diritto al lavoro delle donne e lo considera un presupposto per il diritto di voto. La sua posizione trova eco in alcuni ambienti militanti socialisti, ma soprattutto presso gli intellettuali e accademici comunisti; il capovolgimento dell’Internazionale nel 1935 ha aperto prospettive riformiste e soluzioni nazionali per risolvere la crisi e la disoccupazione di massa. Suo marito Frédéric Joliot condivide questa evoluzione, ma non possiamo sapere se si tratti di una visione partorita insieme e condivisa della coppia, o se di un’interazione progressiva alimentata da un’influenza reciproca.
Mescolando l’antifascismo e il femminismo, Irène arriva a sostenere l’URSS come modello ideologico e politico: «I paesi meno colpiti attualmente dalla campagna condotta contro il lavoro femminile sono la Francia, l’Inghilterra, i paesi in cui il fascismo non ha preso troppo piede. Nell’URSS il lavoro degli uomini e delle donne non è solo un diritto, ma un obbligo, e dove la completa uguaglianza dei diritti è realizzata.»
Nel gennaio 1935, dichiara al giornale “Le Femmes dans l’Action mondiale” che le rende omaggio celebrando «ce savant che sa adempiere così bene i suoi doveri di donna, di madre e di cittadina.»22
Questo è anche il significato delle parole che rivolge a Hélène Gosset, giornalista presso L’Œuvre, nell’agosto 1935 al momento dell’adozione dei decreti-legge Laval volti a rispedire a casa le mogli che svolgevano la mansione di funzionario pubblico ai lavori domestici: «Come femminista, non posso fare a meno di preoccuparmi della condizione sociale delle donne. [...] Pongo una questione che considero indiscutibile: il diritto al lavoro. Ridurre, limitare il lavoro femminile è un’ingiustizia a beneficio degli stolti e dei pigri, per tutti gli altri si tratta di un’ingiustizia tragica.» E continua a proposito dei diritti politici: «Voglio il voto delle donne. Accetterei anche, per cominciare naturalmente, a condizione che sia l’inizio di un percorso, con il voto comunale che sembra spaventare meno la massa maschile...»23 Il diritto di voto delle donne è per lei un’esigenza politica che tuttavia considera secondaria rispetto ai diritti economici e al diritto al lavoro.
Questa posizione diventa il suo leitmotiv pubblico. Il 25 ottobre 1935, alla Mutualité, presiede una manifestazione contro la politica deflazionista di Pierre Laval, presidente del Consiglio, la cui parola d’ordine è «Per il diritto al lavoro delle donne».
Il pericolo viene dalla crisi economica e scrive per “France Vivante”: «In Francia, la situazione economica delle donne è molto negativa, più sfavorevole rispetto alla loro situazione, non certo positiva, in materia civile e politica, ma, nonostante ciò, nuove leggi minacciano di peggiorare ulteriormente questo stato di cose. Queste leggi, oggi, dirette contro la donna sposata che svolge il lavoro di funzionario, non tarderebbero ad estendersi al lavoro femminile in generale, come è già avvenuto in altri paesi.»24
L’allusione è all’Italia di Mussolini e alla Germania hitleriana. Irène Joliot-Curie aggiunge: «Tra le conquiste del femminismo, non c’è niente di più importante che il diritto per la donna di ottenere i lavori per i quali è qualificata dalle sue conoscenze e capacità. […] Il diritto che è stato più aspramente contestato è quello di esercitare mestieri sufficientemente retribuiti, in grado di garantire la sua indipendenza economica».
Ribadisce la sua posizione per George Sinclair, inviata dal “Journal de la Femme”, il 23 novembre 1935, all’indomani della sua nomina al Nobel: «So che la posizione delle femministe teoriche-combattenti – e si conosce la mia alta considerazione per loro – è quella di ottenere prima di tutto i diritti politici delle donne. Certamente, la logica vorrebbe che si ottenessero prima questi diritti, da cui deriverebbero i diritti civili. Ma ho constatato, ahimè, che in alcuni paesi dove le donne avevano conquistato i diritti politici, troppo spesso sono rimaste impotenti nel salvaguardare l’integrità del diritto al lavoro delle donne. Perciò, posso dare la preferenza ad una campagna che si preoccupi prima di tutto di assicurare i diritti civili, che sono le vere condizioni della libertà femminile.»25
Riafferma le sue priorità femministe nel giugno 1936 al settimanale “Le Journal de la femme”,26 all’indomani della sua entrata nel governo di Front Populaire: «Difesa del lavoro femminile, lotta per ottenere i diritti civili, ecco “le vere condizioni della libertà femminile!”». Andrée Viollis spiega a “Le Petit Parisien” del 13 giugno, sotto il titolo “Madame Joliot-Curie”, che la sua entrata al governo deve «servire la causa del lavoro femminile, così minacciata oggi in tutti i paesi.»
Questo conferma un’integrazione delle priorità: i diritti politici verranno aggiunti ai diritti economici. Ormai, il credo del Partito Comunista, a cui si sente più vicina, le scelte di diversi movimenti femministi, del sindacalismo femminile ne rafforzano l’orientamento. Senza inserirsi completamente sotto questo banner, Irène Joliot-Curie ne sposa la linea. Senza mai aderire al Partito Comunista, simpatizza abbastanza per accompagnarlo. Nel maggio 1938, non esita a presiedere l’Unione degli intellettuali per la libertà, la giustizia e la pace per proteggere gli studiosi ebrei e stranieri. Dal 1940, opta per la logica della resistenza e, a partire dal 1942, per la resistenza comunista alla quale già appartiene Frédéric.
Fu quindi negli anni Trenta che la posizione di Irène Joliot-Curie sui diritti politici delle donne si è orientata verso un riformismo prudente, legato al suo impegno antifascista e alla sua analisi della situazione che riassume così in una tribuna di “Femmes Françaises”27 del 30 novembre 1944: «In alcuni paesi, le donne hanno contribuito in modo significativo all’elezione di deputati con tendenze reazionarie che si affrettavano a ridurre i diritti civili ed economici delle loro elettive. Le donne della Repubblica di Weimar, che ottennero il diritto di voto il 12 novembre 1918, non votarono per Hitler assicurando la vittoria del nazismo già nel 1933?».
Imbevuta di principi egualitari, Irène sposa allora sempre più gli ideali marxisti che difendono il Partito Comunista Francese e una frangia marginale della SFIO. Intransigente sulla questione del diritto al lavoro e moderata sul diritto di voto, convinta che la lotta di classe risolverà le rivendicazioni femministe, considera il modello sovietico come la soluzione. È questa la scelta che, all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, sostiene nonostante alcune riserve.
A partire dal 1945, Irène Joliot-Curie è sempre più convinta che la società da lei auspicata annullerà de facto la questione dell’emancipazione delle donne, dato che il diritto al lavoro – e il diritto per le donne di scegliere o meno di lavorare – sarà consacrato. Alla liberazione, aderisce all’Unione delle donne francesi, il cui primo congresso, il 18 novembre 1944, mette in evidenza la difesa della famiglia, la liberazione e la ricostruzione della Francia. È un movimento femminista di massa e di educazione popolare. Irène Joliot-Curie, co-fondatrice, è invitata dalla nuova presidente Eugénie Cotton a prendere la parola. La sua notorietà scientifica, il suo passato politico, il suo impegno femminista, il suo sostegno alla resistenza comunista, tutto contribuisce a fare di Irène Joliot-Curie una recluta di primo piano.
Questo risponde anche alla strategia del Partito Comunista di moltiplicare i movimenti, al fine di ampliare il suo pubblico e la massa dei suoi sostenitori, ed è anche un buon modo per dare alle donne, che hanno finalmente ottenuto il diritto di voto, un posto nuovo. Allora Irène celebra ed evoca la preparazione alle prossime elezioni elettorali nel quadro della restaurazione costituzionale della Repubblica: «Tutte le donne devono essere istruite, preparate alla vita politica, perché hanno finezza, generosità, buon senso.»
Sebbene Irène non abbia mai aderito al Partito Comunista e non abbia militato in altro modo che con i suoi interventi pubblici e i suoi numerosi articoli nelle colonne dei giornali comunisti o dell’ambiente comunista, la sua parola è altamente considerata. La sua aura intellettuale e il suo peso scientifico aggiungono credibilità alla denuncia dei pericoli della corsa agli armamenti nucleari. Ma Irène Joliot-Curie è anche una donna esemplare: esercita il suo mestiere, è moglie e madre, difende i valori dell’educazione democratica. È, quindi, naturale che si preoccupi anche dei diritti economici e sociali delle donne e della loro condizione al termine della guerra. Il suo discorso, che si tratti di educazione, economia, diritti delle donne o scienza, segue sempre la linea guida seguente: la scienza deve concorrere ai benefici dell’umanità e le donne sono garanti della pace.
Nel giornale pro-comunista Femmes Françaises del 30 novembre 1944, sotto il titolo «Ce que les Françaises pensent du vote»,28 Irène Joliot-Curie commenta l’attribuzione del diritto di voto alle donne. In primo luogo, ricorda che si tratta di un diritto indiscutibile: «Penso che la decisione di concedere alle donne il diritto di voto e di eleggibilità sia una misura di giustizia che è stata troppo a lungo differita.» Ma insiste sulla necessità di educare e guidare, ricordando il voto reazionario e nazista delle tedesche che hanno contribuito all’arrivo di Hitler al potere. Il secondo argomento che ha messo in evidenza è la priorità di scelta: «[grazie all’assegno concesso alle donne sposate per permetterle di rimanere a casa,] sono convinta che la maggior parte delle donne sarà felice di essere così esonerata da cercare un lavoro fuori; la maggior parte ma non tutte, altre preferiscono, anche se hanno figli, esercitare una professione di loro scelta.»
L’anno seguente, nel settembre 1945, pubblica in Femmes françaises le sue «Impressions d’URSS» nelle quali si entusiasma per questo modello di nuova società.29 Nel marzo 1946, rappresentante a Londra dell’Unione delle donne francesi, afferma: «Tra le donne, il comunismo dovrebbe essere apprezzato al suo giusto valore. Le rivendicazioni femminili presentate ieri da varie delegate sarebbero prive di oggetto in URSS. Non vi è differenza tra i diritti degli uomini e quelli delle donne, e le donne occupano effettivamente posizioni elevate in tutti i rami dell’attività sociale. La famiglia è protetta e le donne, anche in campagna, hanno facilitazioni che permettono loro di lavorare quando hanno figli.»30 Per lei, è una società ideale che attua l’uguaglianza dei sessi: il femminismo è quindi diventato senza oggetto.
Irène Joliot-Curie è entrata a pieno titolo nella guerra fredda e nella lotta ideologica tra progresso e reazione: «Coloro che hanno questa paura malaticcia del comunismo sono gli stessi che troverete sempre cercando di soffocare le nuove idee: tra loro troverete i nemici di una sincera cooperazione internazionale, così come i nemici delle vere democrazie, i nemici del femminismo e i nemici della pace.» Questa radicalizzazione è stata anche quella di molti intellettuali e scienziati impegnati; è nata dalle disillusioni del dopoguerra che accompagnavano le rinunce dei responsabili politici agli ideali «rivoluzionari» forgiati nella Resistenza e nella Liberazione e rafforzati dalle tensioni Est-Ovest. Progressivamente sconfitta dalla malattia e costretta a soggiorni di riposo, Irène Joliot-Curie ha avuto a malapena il tempo di sospettare i limiti e le ambiguità della sua presa di posizione.
6. Attualità delle vicende umane di Irène Joliot-Curie
Irène Joliot-Curie è quindi più femminista di quanto lo fosse sua madre Marie Curie. In un contesto più difficile, attinge alla sua educazione e poi al socialismo, quei principi egualitari che corrispondono ai suoi ideali. Pertanto, è convinta che la fine del dominio di classe risolverà la questione della parità di genere. A titolo personale, crede nell’impegno, nella militanza e nell’azione rivolti sia al servizio della scienza che della società. La sua ricerca scientifica, dalla radioattività agli elementi transuranici, corrisponde alla ricerca del progresso sociale e dell’emancipazione delle donne, poiché la scienza ha come fine il bene dell’umanità. Da un lato, essa sublima le finalità della scienza e ne respinge ogni uso non pacifico e, dall’altro, fa della democrazia l’alfa e l’omega dei valori universali. Il femminismo diventa allora l’espressione del suo impegno civico, quello di una scienziata imbevuta di valori repubblicani che idealizza ciò che crede di capire dell’URSS, o ciò che le è stato dato da vedere.
Come donna e come madre, Irène Joliot-Curie non si è mai allontanata da una concezione asimmetrica e «naturale» dei due sessi. Ed è nell’ambito della propria famiglia e del proprio matrimonio, che realizza l’uguaglianza intellettuale tra uomo e donna e la condivisione delle responsabilità che essa mira, attraverso una conquista graduale, a poco a poco. Ecco la sua reazione, il 28 dicembre 1942, alla decisione del marito Frédéric di dedicare due giorni alla settimana ai loro due figli: «Credo che sia ottimo per loro, da un lato perché non sono qui, e dall’altro perché puoi fare del bene a loro in modi diversi dai miei. La loro educazione è anche il risultato di una collaborazione in cui ognuno apporta elementi significativi. Purtroppo in questo momento, mio povero tesoro, ti lascio tutto sulle spalle, lavoro scientifico, bambini, conti, ecc. [...] Speriamo che presto cambierà. Nel frattempo, ho sempre guadagnato due chili. [...] Quanto vorrei essere con te, e poterti aiutare invece di essere il peso che ero prima di partire.»31
Poiché la malattia e i soggiorni di cura e di riposo in Alta Savoia o nelle Alpi svizzere la obbligano ad assentarsi, Irène Joliot-Curie è stata probabilmente portata, e il suo coniuge anche, a ripensare la ripartizione dei compiti all’interno della coppia. Il termine «collaborazione» è tuttavia significativo di una sfida di complementarità più che di uguaglianza.
Nel mondo scientifico, si confronta con alcuni bastioni antifemministi come l’Académie des sciences in Francia. Tenace, ha cercato di conquistare l’Accademia quattro volte tra il 1950 e il 1954, senza mai disperare per raggiungere i suoi scopi. Questa istituzione, che dovrebbe rappresentare l’acme dell’intelligenza delle scienze e il vertice del compimento della carriera universitaria, conferendo ai suoi membri cooptati una notorietà nazionale e internazionale, è diventata dalla fine del XIX secolo un rifugio dal conformismo e un cenacolo di antifemministi. Come scrive Irène Joliot-Curie nel 1954, «[Marie Curie] si presentò all’Accademia delle Scienze nel 1910 e fallì, una violenta campagna condotta contro di lei dalle antifemministe e dai clericali»32 concludendo: «L’Accademia delle scienze ha un grande spirito. Io stessa mi sono presentata a diverse volte e non sono stata ammessa.» Per quanto fosse una brillante scienziata, il suo errore era essere una donna.
Diversamente da Marie Curie, che si è tenuta lontana dall’arena politica, Irène Joliot-Curie appartiene a questa generazione mescolata alla crisi, alla politica e alla guerra, che ha affrontato la difesa della democrazia e la speranza del comunismo. Pur differenziandosi dal marito Frédéric Joliot, nell’azione come nella riflessione, Irène Joliot-Curie ha sempre perseguito l’obiettivo politico di far avanzare la causa delle donne.
1 Christine Bard, Les filles de Marianne. Histoire des féminismes, 1914-1940, Paris, Fayard, 1995.
2 Revue Europe, n° 108, décembre 1954, p. 89-121.
3 Leçons de Marie Curie recueillies par Isabelle Chavannes en 1907, Les Ulis, EDP Sciences.
4 Frédéric et Irène Joliot-Curie, Œuvres scientifiques complètes, Paris, PUF, 1961.
5 James Chadwick, Possible existence of a neutron, Nature, 27 febbraio 1932.
6 Irène Curie et Frédéric Joliot, Emission de protons de grande vitesse par les substances hydrogénées sous l’influence des rayons très pénétrants, Comptes rendus de l’Académie des sciences Paris, 1932, 194, 273.
7 Iréne et Frédéric Joliot-Curie, La découverte de la radioactivité artificielle, Atomes, n° 58, spécial issue «Radium et Cancer», gennaio 1951.
8 Ibidem.
9 Irène Curie et Frédéric Joliot, Un nouveau type de radioactivité, Comptes rendus de l’Académie des sciences Paris, 1934, 198, 254.
10 Marie Curie, Radioactivité, Paris, Éditions Hermann, ١٩٣٥.
11 Lettera di Marie Curie à Herta Ayrton, in Evelyn Sharp, Hertha Ayrton, A Memoir, Londres, Edward Arnold & C°, 1926, p. 237.
12 Lettera a Louis Marin, presidente del gruppo femminista al Senato, luglio 1932, in Eugénie Cotton, Les Curie et la radioactivité, Paris, Seghers,1963, p. 196.
13 Archives Curie – Revue de presse Boîte n° 1, n° 5631, titolo: «La vie des femmes va changer» in allusione alla vittoria elettorale del Front Populaire.
14 Le Quotidien del 31 marzo 1925, articolo di Denise Moran, Archives Curie – Revue de presse Boîte n° 1.
15 Mediapart del 18 agosto 2024 – Irène Joliot-Curie, l’étoile filante progressiste – articolo di Antoine Perraud https://www.mediapart.fr/journal/culture-et-idees/180824/irene-joliot-curie-l-etoile-filante-progressiste
16 Dichiarazione di Irène Joliot-Curie alla Radiodiffusion Française (Radio Paris), il 4 luglio1936. Archives Curie, enregistrements radiophoniques.
17 Ironica e senza dubbio un po’ invidiosa, Louise Weiss è severa nei confronti di questa misura che secondo lei non farebbe avanzare la causa suffragista. È ancora più severa con Cécile Brunschvicg, accusata di tradire il femminismo accettando di entrare nel governo, in Combats pour les femmes, Paris, Albin Michel, 1980, p. 123.
18 Ritratto di «Mme Joliot-Curie» della giornalista Andrée Viollis in Le Petit Parisien du 13 juin 1936.
19 Archives Curie, dossier I-15, liasse 39, «Je suis heureuse d’avoir pu l’aider au moment où j’étais sous-secrétaire d’État à la Recherche Scientifique.»
20 Questo luogo di villeggiatura bretone, creato non lontano da Paimpol, riunisce la generazione dei fisici e matematici dreyfusardi (i Borel, i Chavannes, i Maurain, i Pagès, i Perrin, gli Urbain, i Curie, gli Auger, i Gricouroff, gli Stodel) intorno allo storico Charles Seignobos e al fisiologo Charles Lapicque per vacanze sportive e discussioni animate. La scrittrice Camille Marbo dedica un intero capitolo dei suoi ricordi a questo luogo e a questi incontri intellettuali, balneari e sportivi, battezzati Sorbonne-Plage o Fort la Science. Vedere anche Michel Pinault, «Portrait de groupe d’universitaires parisiens en leur villégiature bretonne: l’Arcouest dans la première moitié du XXème siècle», Histoire et Sociétés, n° 25-26, avril 2008, p. 136-157.
21 Irène Joliot-Curie figura come firmataria dell’«Appel des intellectuels contre le fascisme» nel giornale del partito SFIO Le Populaire del 12 marzo 1934.
22 Archives Curie – Revue de presse, boîte n° 1, n° 5581, «L’opinion d’une femme de sciences: Irène Joliot-Curie».
23 L’Œuvre, 21 agosto 1935, «Les Françaises au travail», Archives Curie – Revue de Presse Boîte n° 1, n° 5078, 1934-1935.
24 Archives Curie, testo d’Irène Joliot-Curie «Sur le travail des femmes» in France Vivante, 1935, dossier I-14, liasse 4.
25 Le Journal de la Femme du 23 novembre 1935, articolo di George Sinclair, «Pour les femmes! Mme Joliot-Curie, Prix Nobel, nous dit…», Archives Curie – Revue de presse, boîte n° 1, n° 5594.
26 Archives Curie – Revue de presse Boîte n° 1, n° 5631, «La vie des femmes va changer» in allusione alla vittoria elettorale del Front Populaire. Dichiarazione a Marie-Jeanne Viel del settimanale Le Journal de la Femme, all’indomani della presa dell’incarico ministeriale nel giugno del 1936.
27 Femmes Françaises del 30 novembre 1944, articolo firmato da I. Joliot-Curie, Archives Curie – Revue de presse, boîte n° 1, n° 5730.
28 Femmes Françaises del 30 novembre 1944, articolo firmato da I. Joliot-Curie, Archives Curie – Revue de presse, boîte n° 1, n° 5730.
29 Archives Curie, dossier I-14, liasse 14 Femmes Françaises, septembre 1945.
30 Archives Curie, dossier JC-14, 5 pagine del discorso di Irène Joliot-Curie a Londra.
31 Lettera di Irène a Frédéric, Archives Curie BnF, citato da Rosalynd Pflum, Marie Curie et sa fille Irène. Deux femmes, trois Nobel, Paris, Belfond, 1992, p. 355.
32 Janine Trotereau, Marie Curie, Paris, Gallimard Folio, 2011, p. 180-191.